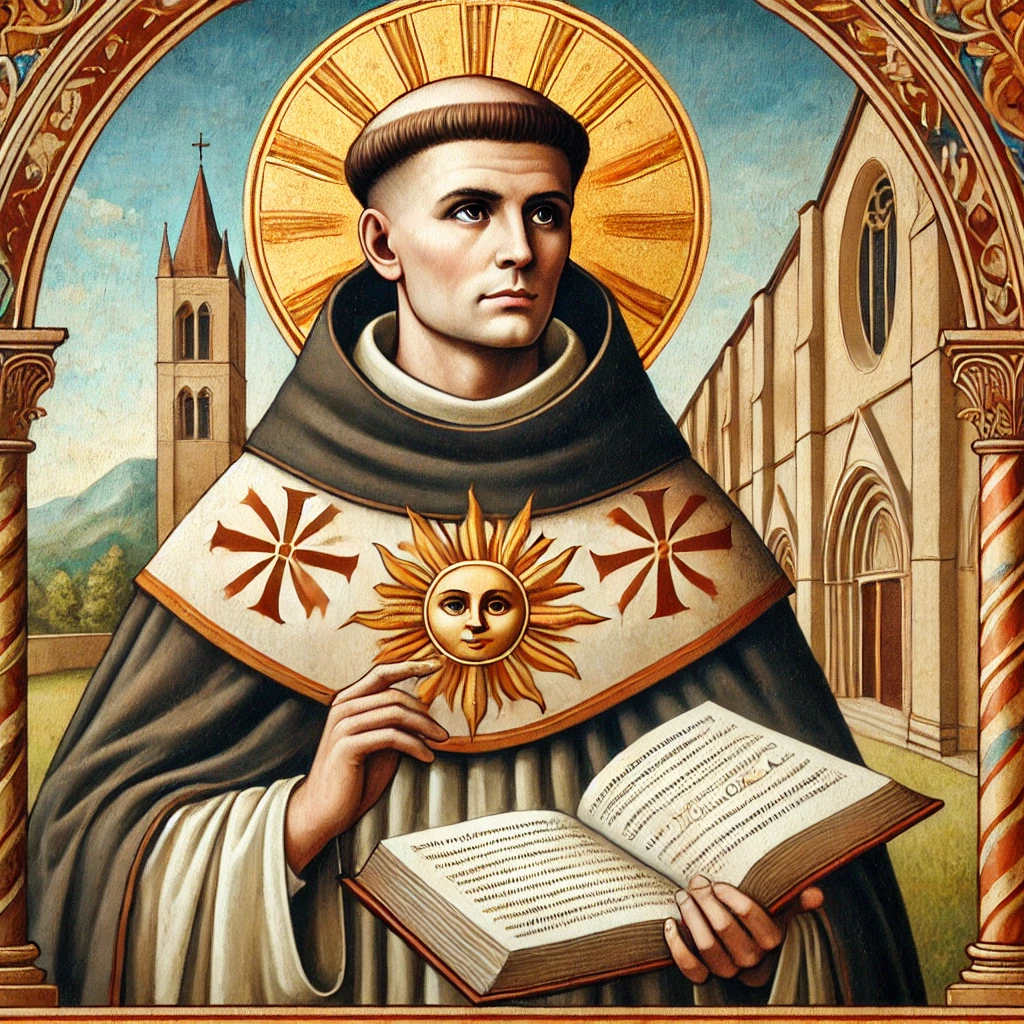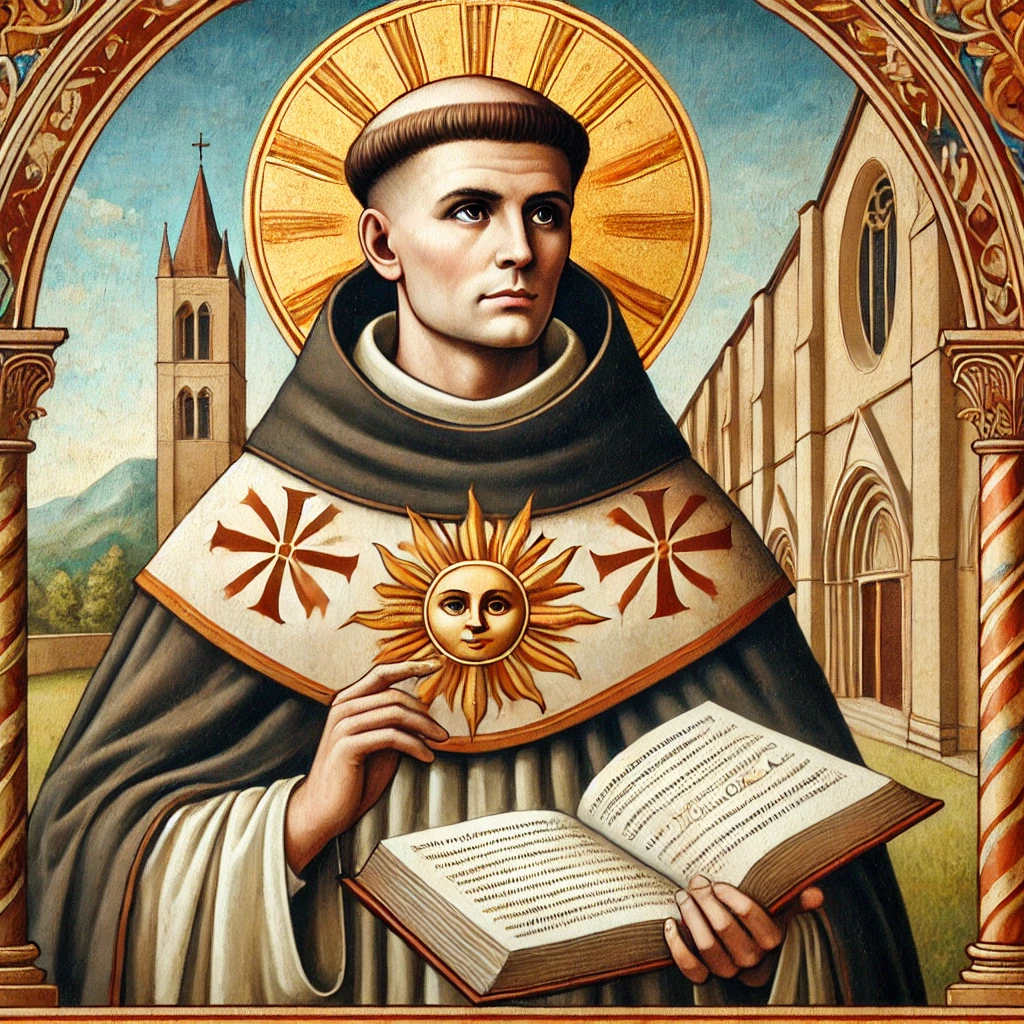
San Tommaso d’Aquino è stato una figura fondamentale nella storia della teologia e della filosofia, tanto che il suo pensiero è diventato il fondamento della dottrina cattolica con l’enciclica Aeterni Patris, promulgata da Papa Leone XIII nel 1879.
LA SINTESI TRA LA FILOSOFIA E LA DOTTRINA CRISTIANA
Tommaso d’Aquino è noto per la sua capacità di sintetizzare il pensiero di Aristotele con la teologia cristiana. Aristotele, essendo un pensatore pagano, era inizialmente considerato con sospetto dalla Chiesa, ma Tommaso riesce a conciliare il suo realismo filosofico con la dottrina cristiana, dimostrando come la ragione e la fede possano coesistere armoniosamente.La sua rilettura di Aristotele si basa su tre principi fondamentali riguardanti la filosofia:
- La filosofia deve fissare i suoi limiti: La filosofia ha un campo di indagine ben definito, legato all’esperienza sensibile e alla ragione naturale. Non può quindi superare i propri confini per spiegare le verità rivelate, che appartengono invece alla teologia.
- La filosofia deve chiarire i preamboli della fede: Secondo Tommaso, esistono delle verità che, pur essendo accessibili alla ragione, fungono da premesse necessarie per comprendere la fede. La filosofia fornisce queste basi intellettuali senza le quali non si può giungere alla comprensione della rivelazione divina.
- La filosofia deve confutare le eresie: Anche gli eretici erano intellettuali e proponevano teorie sofisticate. La filosofia, quindi, ha anche il compito di difendere la dottrina cristiana e confutare errori teologici con argomentazioni razionali.
GNOSEOLOGIA
San Tommaso sviluppa una teoria della conoscenza basata sul realismo aristotelico, secondo cui la conoscenza umana è legata all’esperienza sensibile. La conoscenza filosofica è quindi empirica, cioè fondata sull’esperienza , e segue tre passaggi fondamentali:- Sensazione → Il soggetto entra in contatto sensibile con un oggetto empirico. I sensi forniscono la materia prima della conoscenza.
- Conoscenza intellegibile → L’intelletto estrae dall’esperienza un’immagine mentale dell’oggetto (phantasma).
- Astrazione → L’intelletto attivo astrae dall’immagine un concetto universale, valido per tutti gli oggetti simili.
Se l’uomo è in grado di conoscere la realtà, perché talvolta sbaglia?
L’errore si verifica quando il soggetto esprime un giudizio sbagliato: ciò accade quando non ha perfetta consapevolezza del rapporto tra conoscenza sensibile e fenomeno. Quindi, l’errore non è un limite della realtà, ma una limitazione dell’intelletto umano, che può fraintendere la relazione tra le cose.
San Tommaso sostiene perciò che la conoscenza avviene attraverso immagini sensibili. Il nostro intelletto conosce la realtà partendo dall’esperienza e formando immagini mentali (phantasmata). Il rapporto tra ente e universale è analogico: l’universale esiste realmente, ma non in modo identico in ogni ente. Esiste una gradazione tra gli enti, e ciò è fondamentale per il pensiero teologico.
Inoltre, poiché la ragione è subordinata alla fede, non si può parlare di Dio con un linguaggio univoco (che lo definirebbe in modo rigido) né equivoco (che lo renderebbe incomprensibile). San Tommaso introduce quindi il concetto di analogia, che permette di parlare di Dio a partire dalle esperienze umane: l’essere di Dio e l’essere umano non sono identici, ma simili in modo proporzionale. L’analogia rappresenta quindi il ponte tra filosofia e teologia, consentendo alla ragione umana di avvicinarsi al divino senza pretendere di comprenderlo pienamente.
METAFISICA
San Tommaso sostiene che dall’esperienza si può arrivare a conoscere Dio. A tal fine, elabora cinque vie (termine che richiama le odos di Parmenide), che sono argomenti induttivi a posteriori per dimostrare l’esistenza di Dio:- La via del movimento (o del motore immobile): Tutto ciò che si muove è mosso da qualcos’altro. Non si può risalire all’infinito in una catena di motori, quindi deve esistere un primo motore immobile, che è Dio.
- La via della causa efficiente: Ogni effetto ha una causa. Non può esistere una catena infinita di cause senza un primo principio causale, ovvero Dio.
- La via della contingenza: Tutto ciò che esiste nel mondo è contingente, cioè potrebbe non esistere. I fenomeni sono in continua trasformazione, esistono e poi scompaiono: deve quindi esistere un ente necessario, che esiste di per sé: Dio.
- La via dell'ordine: Il mondo naturale segue un ordine e una finalità. Questo ordine non può essere casuale, ma deve essere opera di un intelligenza ordinatrice, che è Dio.
- Via dei della perfezione: Nell’universo esistono diversi gradi di perfezione (ad esempio, alcune cose sono più buone o più vere di altre). Ci deve essere un modello perfetto che rappresenta la massima perfezione, cioè Dio.
ETICA
San Tommaso d’Aquino sviluppa un’etica intellettualista, ponendo al centro della sua riflessione il rapporto tra l’uomo, la sua capacità di conoscere il bene e la sua libertà di agire. Secondo il pensatore domenicano, l’essere umano è dotato di libero arbitrio, ovvero della facoltà di scegliere tra il bene e il male. Tuttavia, l’errore morale non deriva da una malvagità innata, ma dall’incapacità dell’uomo di comprendere l’ordine naturale delle cose.Nel pensiero tomista, l’universo è strutturato secondo un’ordinata gerarchia ontologica, in cui ogni ente possiede una propria finalità stabilita da Dio. Questo ordine della natura non è casuale, ma segue precise leggi razionali che l’intelletto umano, grazie alla sua capacità conoscitiva, è in grado di cogliere. L’uomo, essendo dotato di anima razionale e corpo, ha la possibilità di riconoscere il bene attraverso la conoscenza della realtà e delle leggi che la regolano.
Tuttavia, a differenza della concezione intellettualista socratica, per cui conoscere il bene porta necessariamente a compierlo, San Tommaso introduce una distinzione fondamentale: pur conoscendo il bene, l’uomo può scegliere il male. Questo accade perché la volontà, che è libera, può essere sviata da passioni, desideri disordinati o errori di giudizio. Il peccato, quindi, non è semplicemente mancanza di conoscenza, ma una deviazione volontaria dall’ordine stabilito da Dio.
Un elemento centrale nell’etica di San Tommaso è la distinzione tra legge naturale e legge divina:
- La legge naturale è la partecipazione della legge eterna di Dio nella ragione umana e permette all’uomo di comprendere ciò che è giusto attraverso la sua facoltà razionale.
- La legge divina, invece, è la rivelazione che Dio ha fatto agli uomini, e si manifesta soprattutto nelle Sacre Scritture.
POLITICA
San Tommaso d’Aquino non si limita a riflettere sulla morale individuale, ma elabora anche una teoria politica in cui cerca di conciliare l’eredità della filosofia aristotelica con la dottrina cristiana. Nella sua opera principale di filosofia politica, il De Regno, San Tommaso sostiene che la monarchia sia la forma di governo ideale, poiché più di ogni altra garantisce ordine, unità e stabilità nella società.La sua preferenza per la monarchia deriva da una concezione dell’ordine sociale che riflette l’ordine naturale e divino : così come nell’universo esiste una gerarchia voluta da Dio, anche nella società deve esserci un’autorità unica che governi con giustizia e saggezza. In un governo monarchico, un solo sovrano agisce come guida e garante del bene comune, evitando le divisioni e i conflitti tipici dei governi oligarchici o democratici.
Tuttavia, San Tommaso introduce un elemento fondamentale: il potere del sovrano non è assoluto, ma subordinato alla legge naturale e alla legge divina. Se il re governa in modo ingiusto, allontanandosi dai principi del bene comune e dell’ordine divino, allora il popolo ha il diritto di opporsi alla sua autorità. In questo senso, Tommaso introduce una prima idea di legittimità del potere politico, che non si fonda solo sulla forza, ma sulla sua conformità alla giustizia.
Un altro aspetto cruciale della sua riflessione politica riguarda il rapporto tra Stato e Chiesa. San Tommaso, pur riconoscendo l’importanza del potere temporale, afferma che la Chiesa deve avere la supremazia sul potere politicoù , perché la sua missione riguarda non solo il governo della società, ma la salvezza eterna delle anime.
Questa visione si basa su una concezione gerarchica dell’ordine dell’universo:
- Lo Stato ha il compito di garantire il benessere terreno e l’ordine civile.
- La Chiesa, invece, guida l’uomo verso la beatitudine eterna e possiede un’autorità superiore, poiché si occupa del fine ultimo dell’esistenza umana.
In conclusione, la riflessione di San Tommaso d’Aquino in ambito etico e politico si fonda su un’armonia tra ragione e fede, ordine naturale e ordine divino. L’uomo è libero di scegliere tra bene e male, ma la sua libertà deve essere esercitata in conformità con l’ordine stabilito da Dio. Allo stesso modo, il potere politico deve garantire il bene comune, ma sempre nel rispetto della legge divina e sotto la guida della Chiesa, che rappresenta l’autorità suprema in materia di verità e salvezza.